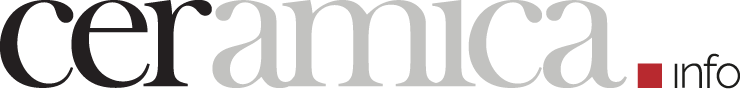Interviste

Architettura (più) Luogo (più) Arte | di Alessandra Coppa
Gino Garbellini, ingegnere valtellinese (più) Francesco Fresa, romano che ha studiato a Berlino (più) Germán Fuenmayor, venezuelano (più) la milanese Monica Tricario, uguale Piuarch, insieme dal 1996. Quattro amici e colleghi, nello studio di Vittorio Gregotti dalla metà degli anni ottanta per dieci anni, hanno dato origine a un “laboratorio di progettazione”, una storia autonoma dal “maestro” e emblematica di un nuovo “professionismo italiano” di fare architettura di qualità, senza manie di protagonismo, in Italia e all’estero, lavorando su diversi temi e su diverse scale con una particolare sensibilità per il dialogo con il luogo, per l’interazione con l’arte e l’attenzione al dettaglio.
“Piuarch” significa apertura, saper fare confluire approcci e punti di vista diversi in un unico progetto con il contributo di consulenti di diverse discipline.
Lo studio, un open space ricavato da uno spazio industriale che ospitava un tempo una tipografia con un orto sul tetto, si trova in via Palermo a Milano, nel cuore del Brera District.
Vi siete conosciuti nello studio di Gregotti, qual è l’eredità di questa esperienza e come avete invece pensato il vostro modo di lavorare insieme “dopo”?
L’eredità del “maestro” c’è ma non è pesante. L’aspetto positivo è il fatto che è stata l’occasione per conoscere i miei soci e che quell’esperienza abbia rappresentato una sorta di emancipazione nel percorso, utile per formarci, ma che poi abbiamo facilmente lasciato alle spalle. E’ stata importante per formare la nostra capacità di confrontarci con tutte le scale. C’era una grande concentrazione di lavori e noi giovani siamo stati buttati subito sulla ribalta. Lavoravamo insieme e ci siamo “individuati come gruppo”.
Lavoravate in gruppo da Gregotti?
Forse nello studio di Gregotti non si lavorava proprio in gruppo, aleggiava la guida del grande maestro… Noi invece abbiamo un’idea di “laboratorio” dove non ci dividiamo i ruoli; siamo uno studio dove non ci sono regole, c’è un buon equilibrio di completamento. Siamo usciti con la voglia di guardare avanti e fare qualcosa di nuovo, non con quella di dimenticare.
Ci parli del vostro primo lavoro che avete portato a termine, le case popolari nell’area Ex Falck a Sesto San Giovanni e l’ultimo, la sede di Gucci in via Mecenate a Milano. Quali sono le continuità e i cambiamenti all’approccio progettuale?
Il primo edificio che abbiamo realizzato è stata un’esperienza straordinaria che abbiamo ancora nel cuore: il complesso di edilizia residenziale sovvenzionata Fola a Sesto San Giovanni, un tema forte in quegli anni perché si tentava di fare edilizia popolare ma di qualità con un uso sperimentale del legno. I nostri riferimenti citavano Terragni, eravamo giovani. Un intervento un po’ scolastico nel disegno tuttavia molto ricercato, attento al dettaglio. L’ultimo in cantiere è la sede di via Mecenate di Gucci. Si differenzia dal primo per la dimensione, ma forse anche per il distacco dal dettaglio o meglio per la capacità di leggere il dettaglio non in sé ma come parte di un insieme. L’edificio è inteso come una sorta di organismo: qui il dettaglio è molto più complesso perché il nuovo si confronta con un’architettura industriale.
Luca Molinari ha scritto che entrare nel mondo dei Piuarch significa “confrontarsi con una dimensione inusuale del professionismo italiano e insieme con una realtà nuova in crescita”…
Noi quest’anno festeggiamo i vent’anni. Sono un bel traguardo e un bell’esempio di multi-professionalità. E’ quel tipo di professionismo che vuole uscire dall’idea di protagonismo, per presentarsi con le “cose fatte”, mostrarsi attraverso i progetti realizzati, una modalità di comunicazione che a nostro avviso vale di più. Già il fatto di avere un nome che “non è un nome”, evidenzia l’idea dell’insieme ma anche dell’apertura del “più”, nel senso di mettere in connessione più persone anche per le consultazioni esterne.
Mi sembra che pensiate e progettiate architettura a prescindere dagli stili e dai linguaggi per porre al centro del progetto la “qualità” e il dialogo con il “luogo” dove verrà costruito.
Certo, il confronto con il sito sul quale dovremo realizzare il progetto è un fatto centrale per il nostro lavoro. E’ come una condizione al contorno. E’ la prima cosa che fai quando sei in un posto nuovo: ti guardi intorno. Quello che c’è intorno ti suggerisce, ti trasmette degli input. Ma credo che il contesto non sia semplicemente il sito, il contesto è anche quello che non si vede, è la “cultura” del luogo in cui sei. Anche l’arte, parte integrante del nostro lavoro, fa parte del contesto. Un contesto non solo fisico ma anche percettivo che per me significa “contaminazione”.
Vorrei leggere i vostri progetti attraverso parole-chiave che li caratterizzano: filtri/facciata, basic/materiali, lusso/dettaglio, corti/urbano, città/paesaggio. Riesci ad associarle a un vostro edificio realizzato?
“Filtri/facciata” lo associo al Bentini headquarter (Faenza, Ravenna 2009-2011) perché in questo caso il contesto è il nulla, una campagna di per se’ non particolarmente caratterizzata viene disegnata con dei “filtri”: dei grandi “quadratoni” che portano l’esterno all’interno, inquadrandolo. Per “basic/materiali” metterei l’edificio di Porta Nuova a Milano perché è caratterizzato da una cornice bianca, il bianco dà omogeneità al progetto. Abbiamo utilizzato semplicemente un intonaco per la facciata che è tuttavia in grado di far raggiungere una sorta di “astrazione”. Il materiale sottolinea la forma. Il tema lusso/dettaglio coinvolge invece tutti gli edifici che abbiamo realizzato per la moda, dove l’architettura è fatta della somma dei dettagli. Per “corti/urbano”, sicuramente il Business Centre Quattro Corti, che si trova nel nucleo storico della città di San Pietroburgo. Un edificio che rispetta le facciate storiche dentro al quale sono state scavate quattro corti per illuminare gli spazi interni, con funzione di luogo di incontro aperto a installazioni artistiche, mostre e altre attività pubbliche. Mentre per “città/paesaggio” direi il progetto per Riva del Garda, tuttora in costruzione, perché il complesso si rapporta al lago e alla montagna.
Per Dolce & Gabbana avete progettato gli uffici di Milano nel 2006 e cinque anni prima la factory Incisa in Val d’Arno. Com’è stato il rapporto con la committenza?
E’ stata una grande occasione per crescere misurandoci con progetti di alta qualità. Il confronto con Dolce & Gabbana è stato difficile perché sono stati molto esigenti – ci sono stati scontri di protagonismo, il loro e il nostro – nel senso che in questo caso la committenza si doveva rappresentare attraverso l’architettura: gli edifici raccontano il loro modo di fare moda.
Avete realizzato anche l’edificio in piazza Gae Aulenti a Milano Porta Nuova, che citavi prima, in una posizione difficile per il suo “ruolo di cerniera urbana”…
La volontà era quella di rompere le regole che il masterplan imponeva, poiché tendeva a chiudere le visuali e concentrarsi sulla piazza. Il nostro edificio è invece basso, contrariamente al bando che ne richiedeva uno alto. Ha la stessa altezza degli edifici storici del quartiere, e connette la piazza chiusa e introversa con la passerella aerea che attraversa Gioia verso piazza della Repubblica e il futuro parco.
In occasione del Salone 2015, nel cortile dell’Università Statale di Milano, avete realizzato un’installazione per Interni dove c’era un interessante interazione tra ceramica e architettura.
Abbiamo pensato a un’installazione che utilizzava le piastrelle, che abbiamo realizzato per Marazzi con un disegno che cita Gio Ponti. Una stessa piastrella genera geometrie diverse. L’idea è stata quella di utilizzarla per un gioco di riflessioni che ha messo in risalto alcuni elementi architettonici del patio della Statale. L’istallazione si chiamava Punti di Vista e intendeva stimolare una riflessione sulle caratteristiche architettoniche del contesto. Gli elementi classici dell’architettura dell’Università Statale – il fregio, la colonna e l’arco – venivano scomposti in figure geometriche pure, dalle quali nasceva uno spazio interattivo. Le tre forme architettoniche, rivestite con i grès Mystone di Marazzi, permettevano di guardare ‘in’, guardare ‘verso’ e guardare ‘attraverso’: i visitatori, avvicinandosi ed entrando nelle strutture, potevano vivere esperienze di riflessione e visione, da quella totalmente immersiva a giochi caleidoscopici.
Sono le stesse piastrelle che compongono il piano del tavolo che si trova nel vostro Orto sopra lo studio?
Sì, proprio quelle. L’operazione “Orto tra i cortili” è stata voluta principalmente per noi, per dare qualità allo spazio del tetto del nostro studio.
E’ una sorta di metafora di natura-architettura?
Intendo la natura come un altro modo di contaminare il nostro lavoro, non è una priorità, ma una possibilità, è un fatto che mi appartiene. L’orto aiuta a progettare, a lavorare insieme.